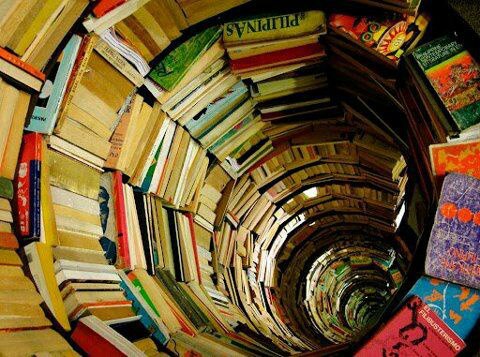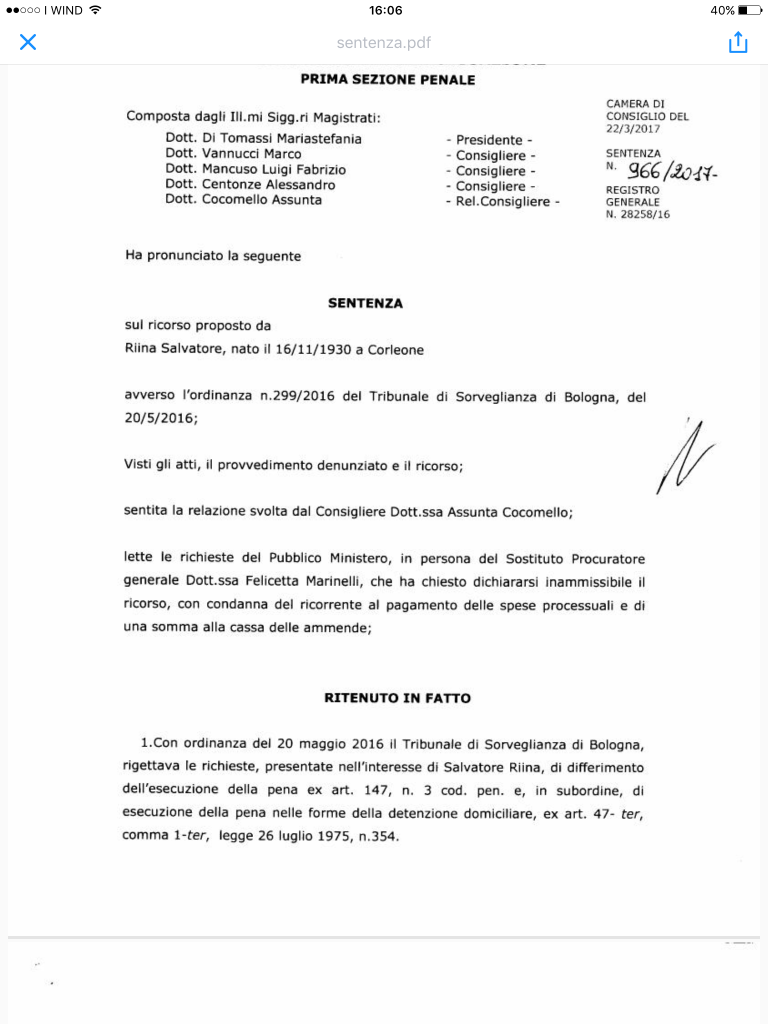L’esperto giudice Giovanna Ichino ne ha viste tante ma un processo così mai. Osman Matammud, 22 anni, somalo, viene accusato di avere sequestrato centinaia di connazionali in un campo da lui gestito in Libia, ucciso quattro persone e stuprato decine di donne. Oggi, chiamata dalla difesa, è venuta a deporre la moglie dell’imputato che vive a Roma e non lo vede da anni. Con sé ha una bimba coi codini di 4 anni. Mentre la mamma testimonia per due ore davanti alla Corte d’Assise, la piccola passa il tempo disegnando in una stanza adiacente.
Alla fine dell’udienza, il legale di Matammud, l’avvocato Gianni Rossi, chiede al presidente Ichino se è possibile un breve saluto dalla gabbia dove siede il suo assistito tra Matammud, la moglie e quella bimba che è la figlia del ragazzo e lui non ha mai visto prima d’ora. Il magistrato si spinge oltre con un gesto definito dall’avvocato Rossi “di grandissima umanità”. Va via dall’aula assieme agli altri giudici disponendo che le sbarre si aprano. La bimba può così abbracciare e riempire di baci per la prima volta il suo papà. Per lei l’uomo indicato dalla legge come un presunto aguzzino e che per il suo avvocato è la vittima innocente di un conflitto tra clan è solo il papà di cui la mamma le ha parlato per tanto tempo. Dieci minuti tra gli sguardi inteneriti di tutti i presenti in un’aula di Tribunale illuminata da una presenza infantile, come mai accade (i minori non possono entrare). La gabbia si chiude ma un agente della polizia penitenziaria vedendo la bambina esitare ad andarsene decide di spalancarla per l’ultima volta:”Dai, vai a salutare il tuo papà”. E lei corre. (manuela d’alessandro)