Ecco il testo della sentenza con cui il Tribunale Civile di Roma ha respinto la richiesta di risarcimento calcolato in 75mila euro avanzata dall’Inpgi nei confronti dei cronisti Manuela D’Alessandro e Frank Cimini per questo articolo
Ecco il testo della sentenza con cui il Tribunale Civile di Roma ha respinto la richiesta di risarcimento calcolato in 75mila euro avanzata dall’Inpgi nei confronti dei cronisti Manuela D’Alessandro e Frank Cimini per questo articolo
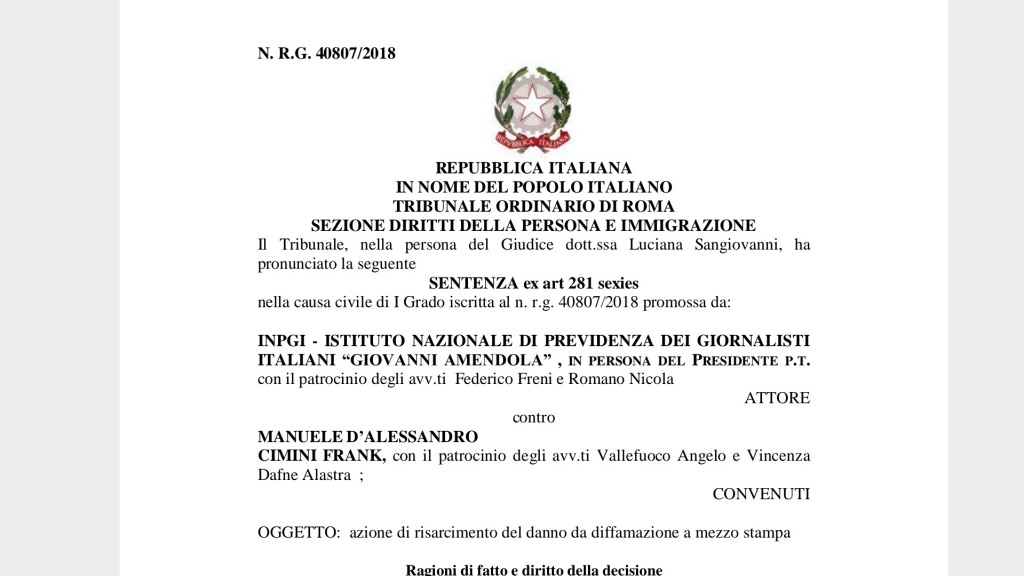
“Beato chi ha fiducia nella giustizia perché sarà giustiziato” è il motto del nostro blog. E invece questa volta abbiamo fatto bene ad avere fiducia nel Tribunale Civile di Roma che ha sancito la nostra vittoria nei confronti dell’Inpgi, l’ente pensionistico dei giornalisti, per l’articolo in cui censuravamo l’operato del suo allora presidente coinvolto in una vicenda giudiziaria da cui poi è uscito assolto. Ma torniamo alla sera del giugno 2018 quando ci vediamo recapitare via posta una richiesta di risarcimento per danni quantificati in 50mila euro più una sanzione pecuniaria da 25mila euro per diffamazione dell’ente in persona. Settantacinquemila euro per avere posto dei dubbi, in nome di quello che oggi il giudice Luciana Sangiovanni definisce “legittimo esercizio del diritto di critica politica in ordine a un evento correttamente riportato”, sulla mancata costituzione di parte civile dell’ente in un procedimento in cui, in teoria, erano stati lesi i diritti dei giornalisti suoi iscritti. Potete immaginare lo sgomento di fronte a quella somma. Coi tempi della giustizia civile arriva una sentenza che dà ragione su tutta la linea alle tesi dei nostri legali e condanna l’ente al pagamento di 4.850 euro di spese legali che, per la cronaca, saranno sempre gli iscritti a pagare. Il giudice ha riconosciuto: “l’interesse pubblico dell’informazione su una vicenda che ebbe un forte impatto mediatico tanto da coinvolgere la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze”; “il legittimo esercizio del diritto di critica politica in relazione a un evento di cronaca giudiziaria correttamente riportato, con l’uso sapiente del condizionale e della forma dubitativa sintomatica dell’assenza di ogni intenzione manipolativa o lesiva”; il fatto che “ai fini della verità a nulla rileva la costituzione di parte civile dell’Inpgi un anno dopo la pubblicazione dell’articolo e l’assoluzione di Camporese per il reato ascrittogli”.
C’è stato un momento in cui avremmo potuto chiudere la faccenda con qualche centinaio di euro. I legali dell’Inpgi, ora presieduto da Marina Macelloni, in sede di mediazione ci hanno chiesto una somma simbolica come via d’uscita. Abbiamo detto no dichiarando al mediatore che andavamo avanti perché la vicenda non riguardava solo noi ma il diritto di cronaca. E ora i ringraziamenti: ai nostri avvocati Valerio Vallefuoco e Dafne Alastra che si sono spesi ‘pro bono’; al presidente dell’Ordine dei Giornalisti lombardo Alessando Galimberti che sin da subito si è esposto al nostro fianco; a una parte molto minoritaria del sindacato; ai tanti colleghi che ci hanno espresso solidarietà. A Massimo Bordin, che scrisse un articolo in nostra difesa molto sentito. A lui, maestro di garantismo, la nostra dedica.
(frank cimini e manuela d’alessandro)
(foto di Jari Pilati)
La gip delle scarcerazioni, Donatella Banci Buonamici, l’ha saputo così. Ha bussato in cancelleria per depositare il decreto di fissazione dell’incidente probatorio, con tanto di consulente indicato, e gli impiegati le hanno detto ‘siamo spiacenti, ma lei non si occupa più dell’ indagine sull’incidente della funivia del Mottarone’.
Pare che ci sia rimasta parecchio male sfogandosi perfino coi legali degli indagati. Il caffé freddo - il caffé è importante in questa storia – gliel’ha servito il suo presidente Luigi Maria Montefusco, quello che le aveva manifestato “piena e convinta solidarietà” per le minacce ricevute dopo che aveva liberato due dei tre indagati (Luigi Nerini ed Enrico Perrocchio) e al terzo, Gabriele Tadini, aveva concesso i domiciliari. Dopo, Olimpia Bossi, la pm che li aveva fatti finire dentro ritenendo che a loro carico vi fossero gravissimi indizi, aveva dichiarato ai giornalisti che non avrebbe più bevuto il caffé con la collega magistrata nel palazzo di giustizia di Verbania. Anche perché, racconta a Giustiziami una fonte, durante l’udienza in cui si discutevano le sorti dei tre fermati le due se ne erano dette di ogni con la giudice che invitava la pm a leggersi bene le leggi prima di buttare in galera la gente.
Ma perché Banci Buonamici non si occuperà più del caso?
Qui abbiamo documenti ufficiali e ipotesi.
La carta è quella in cui il presidente Montefusco spiega che l’ex giudice milanese ha finito la sua supplenza e deve tornare la titolare della scrivania, gip Elena Ceriotti, a cui erano stati concessi quattro mesi di “esonero dalla funzione” a causa della “grave sofferenza del suo ufficio”. Non è chiaro per quale ragioni, ma Ceriotti non riusciva più a districarsi trai fascicoli. Adesso però è ritemprata per decidere sulla richiesta della Procura di annullare le scarcerazioni della collega. Pare che a influire sulla decisione di Montefusco sia stata anche una lettera ricevuta dal procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo.
Come che sia, con quale serenità la nuova gip si trova a decidere sugli indagati? C’è chi, come il giornalista Nicola Porro, sostiene che Banci sia stata fatta fuori perché troppo garantista, per avere mostrato al mondo quello che, nonostante i caffé con la collega, dovrebbe fare un giudice sano: esercitare in autonomia il controllo sulla privazione della libertà personale dei cittadini. Qualcuno nei corridoio del Tribunale di Verbania fa notare che Ceriotti è molto fragile in questo momento della sua vita professionale proprio perché è stata in panchina tanto tempo e ora viene buttata in mischia nella partita più importante mai vista nel piccolo tribunale piemontese.
La sensazione di qualcosa di “anomalo” c’é. Lo dice l’avvocato Pasquale Pantano, legale di Nerini: “La legge dice che il giudice va scelto sulla base delle regole decise al momento della nomina. Questo me l’hanno insegnato a scuola, questo lo dice la giurisprudenza, il resto io non lo so”.
Peraltro, Banci si era “assegnata il procedimento” dopo i fermi con un provvedimento condiviso col suo presidente perché la sostituta di Ceriotti, giudice Palomba, era “impegnata in un’udienza dibattimentale”.
Nel motivare la sua sostituzione, Montefusco scrive che “tale assegnazione, se giustificata per la convalida del fermo, non é conforme alle regole di distribuzione degli affari e ai criteri di sostituzione dei magistrati”. Insomma, era una sostituzione solo per il fermo, sembra chiarire. Eppure Banci gli aveva parlato di “procedimento”.
E come mai si è aspettato tutto questo tempo per prenderne atto recapitando il caffé freddo all’ignara Banci che, almeno una telefonata, viste le minacce subite, se la aspettava? Più passano le settimane più la gestione del caso con indagini esplicitate passo dopo passo sui media compresi caffé, lotte intestine e inediti cambi di giudice in corsa, sembrano confermare il momento buio della magistratura italiana.
(manuela d’alessandro)
Non c’è la “prova certa” che sapesse che erano in corso due processi conclusi con altrettante condanne a suo carico, per tentata rapina e resistenza.
Nel provvedimento letto dall’AGI con cui è stata accolta l’istanza dell’avvocato, i giudici fanno riferimento alla recente Cassazione nella quale viene spiegato che non basta l’elezione di domicilio presso un difensore d’ufficio per dimostrare che la persona sia a conoscenza di essere sottoposta a un procedimento penale.
Ci vuole di più: “il giudice deve verificare che vi sia un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l’indagato, tale da far ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento o vi si sia sottratto volontariamente”.
E, scrivono i giudici della Corte d’Appello, “dalla lettura della documentazione riversata nel dossier processuale si evince che le notifiche relative ai due procedimenti sono state sempre effettuate nel domicilio eletto presso il difensore d’ufficio, senza che sia stata raggiunta la prova certa che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario, peraltro affetto da malattia psichiatrica che verosimilmente ha inciso sulla capacità di cognizione e comprensione”.
La conseguenza è che viene ordinata “l’immediata scarcerazione” e la sospensione dell’esecuzione delle due sentenze col rinvio degli atti ai giudici di primo grado davanti ai quali dovranno essere ricelebrati i processi.
L’uomo aveva da scontare un cumulo di 4 anni di reclusione, frutto di due condanne pronunciate dal tribunale di Milano il 13 marzo 2018 e il 2 ottobre 2019. Per quanto riguarda il primo procedimento, dagli atti emerge che parte delle responsabilità vanno attribuite all’allora avvocato d’ufficio che non ha mai partecipato alle udienze tanto che il giudice, dando conto della sua “continua e ingiustificata assenza”, l’ha definita “una cosa veramente ignobile”.
Anche dell secondo giudizio non ha saputo nulla anche per un errore di notifica: “inspiegabilmente” l’avviso di chiusura delle indagini e il decreto di citazione a giudizio vengono mandati a un difensore d’ufficio che non era quello nominato in un primo momento.
Pure in questo caso, come nel primo, “la non conoscenza incolpevole ha determinato il venir meno della possibilità di impugnare la sentenza e la conseguente definitività”. “Sentenze – ha scritto Calcaterra nel ricorso poi accolto – che sono la conclusione di un percorso giudiziario costellato da violazioni di diritti (prima tra tutti quello di difesa) e che rischiano di vanificare la cura di una persona che necessita anzitutto di essere presa in carico per la gestione di quelle problematiche psichiatriche che hanno dato causa ai fatti illeciti”. (manuela d’alessandro)
Nel lontano 12 agosto del 1982, vigente ancora il vecchio codice di procedura penale, venne approvata una legge importante per ovviare alle molte carcerazioni preventive che in quegli anni emergenziali venivano disposte sia dai pm che dai Giudici istruttori, perché ai tempi era una facoltà (e talvolta persino un obbligo) di entrambi.
La legge n. 532 istituì quindi un apposito organo speciale del Tribunale composto da tre magistrati diversi da quello che aveva disposto la carcerazione preventiva, appositamente deputati al controllo dell’arresto di un imputato in corso di indagini e non ancora dichiarato colpevole da nessuna sentenza di merito.
In ragione del preciso obiettivo per il quale era stato istituito, detto organo venne chiamato Tribunale della libertà, anche se sin dall’origine la sua competenza era stata estesa anche ai provvedimenti di sequestro di cose, e non solo a quelli relativi alla libertà personale.
Con la successiva introduzione del nuovo codice di rito del 1989, l’istituto venne mantenuto anche se, con il tempo, all’originaria denominazione di Tribunale della libertà si preferì attribuirgli quella più neutra di Tribunale del riesame, anche sulla scorta del testo della norma di cui all’art. 309 Cpp che parla appunto di “riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva”.
Ma quello che ha profondamente modificato nel corso degli anni il significato originario di quell’importante riforma non è certo stato il cambio del nome, bensì l’evoluzione, che a mio parere sarebbe più corretto definire involuzione, che detto istituto ha subito, a causa di una prassi giurisprudenziale che, sempre a mio parere, ha non di poco stravolto quei principi cui si era ispirato il legislatore del 1982.
Tanto che, parlo per esperienza personale (ma credo di interpretare quella più corrente tra i miei colleghi penalisti), ormai si preferisce evitare il ricorso a detto istituto per evitare che la futura posizione processuale del proprio assistito subisca effetti pregiudizievoli.
Elenco le tre ragioni principali che hanno condotto me (ed altri) a una siffatta conclusione, e che sono il risultato di una ormai inamovibile prassi sedimentatasi nel corso degli anni, forse anche al fine di disincentivare un ricorso pretestuoso a detto rimedio che, prevedendo termini di scadenza molto brevi, nonché una competenza territoriale estesa all’intero distretto di Corte di Appello (si pensi che il TDR di Milano ha competenza su Como, Monza e Varese), avrebbe potuto “intasare” il lavoro dei magistrati appositamente preposti.
La prima “innovazione” giurisprudenziale, prontamente avallata dalla Suprema Corte di Cassazione, è stata quella dell’invenzione del cosiddetto “giudicato cautelare”, un singolare principio in materia di privazione “cautelare” della libertà, e che dovrebbe essere, per definizione, soggetta a diuturna rivalutazione fino a sentenza definitiva, che fa si che in caso di rigetto dell’originaria domanda di riesame, il detenuto debba rimanere in carcere fino al termine massimo di durata della misura, salvo che non emergano “fatti nuovi”.
Fatti nuovi che ben difficilmente dall’interno di una cella il detenuto è posto nelle condizioni di reperire, o che ancora più spesso non sono reperibili neppure volendo e potendo, perché, in caso tanto per dire di contestazione sulla qualificazione giuridica e non sul fatto, non ci possono essere “fatti nuovi” se non il futuro esito del processo.
E’ evidente che di fronte a quel rischio, molto “concreto” vista la tendenza alquanto restrittiva dell’odierno Tribunale del riesame, che, non lo si dimentichi, è spesso “investito” da Ordinanze corpose e complesse, per completare le quali un GIP magari ha impiegato dei mesi, sia preferibile evitare il passaggio da quelle “forche caudine”, affidandocisi al tentativo di lentamente convincere il proprio giudice preliminare di un successivo affievolimento della misura originariamente disposta.
E quindi si rinuncia a quel previsto immediato controllo da parte di tre giudici “terzi” sull’arresto preventivo disposto da un GIP in assenza di contraddittorio e sulla sola base della richiesta del PM.
La seconda, e non meno rilevante interpretazione giurisprudenziale, è stata quella di far sempre premettere alle motivazioni di rigetto un’accurata disamina degli indizi a carico del reo fino a redigere una vera e propria sentenza di condanna anticipata, anche quando oggetto di devoluzione (che in materia di impugnazioni dovrebbe costituire un principio cardine del nostro rito) era esclusivamente la sussistenza o meno delle esigenze cautelari che giustificavano l’arresto provvisorio di un gravemente indiziato di reato, e non già la congruità provvisoria del quadro indiziario.
E questo, persino in quei casi in cui ad essere devoluta è solo l’intervenuta attenuazione di quelle esigenze al fine di una sostituzione della misura in atti in altra meno gravosa e pure prevista dall’Ordinamento, perché, tanto per fare un esempio, nel frattempo è intervenuto l’interrogatorio di garanzia avanti al GIP in cui l’indagato ha risposto.
Anche qui è evidente che di fronte al rischio concreto di vedersi costruire una sentenza anticipata di condanna, che magari “raddrizza” alcune lacune dell’iniziale provvedimento del GIP, e così inevitabilmente pregiudicare il futuro processo di merito, un legale preferisca nuovamente evitare detto passaggio.
Non si dimentichi che le ordinanze del TDR vengono acquisite al fascicolo del dibattimento prima che inizi la verifica orale delle prove raccolte dal PM, con tanti saluti al giudice di merito “vergine”, che si voleva preservare con la riforma del 1988.
Infine, neppure la tempistica più rapida del TDR può venire ormai incontro alla legittima esigenza del detenuto provvisorio di ottenere un’urgente valutazione del proprio stato coercitivo, perché da qualche anno viene ritenuto rispettato il termine di decisione con il solo deposito del dispositivo, a nulla rilevando i tempi occorrenti per il successivo deposito della motivazione del diniego.
Accade così che il detenuto apprenda che per il TDR è necessario che continui ad attendere il proprio processo in carcere senza conoscerne le ragioni, e che il suo legale non possa chiedere, nei tempi originariamente previsti dalla legge, il controllo di legittimità della Cassazione su quel diniego, Cassazione che, a sua volta, impiega come minimo qualche mese prima di fissare il ricorso, da quando il fascicolo perviene a Roma.
La conclusione finale è che oggi come oggi l’istituto del Tribunale del riesame ha perduto gran parte delle prerogative per il quale era stato istituito quasi quarant’anni fa, anche se l’emergenza di allora non pare molto mutata, visti i numeri sempre molto alti nel nostro Paese di carcerazioni preventive.
Quello che suona un po’ paradossale è che ai tempi non vi era neppure un ufficio apposito con magistrati incaricati solo di detta funzione, ma si ricorreva alla rotazione di quelli dislocati presso le varie sezioni penali del Tribunale che avevano il mese di turno.
Oggi, che anche per venire incontro al sempre più crescente ricorso alla custodia cautelare è stato tutto meglio organizzato, con magistrati di ruolo, uffici, aula speciale, cancelleria ecc, a quello che era stato il glorioso Tribunale della libertà, non ci si va più, o… quasi.
avv. Davide Steccanella